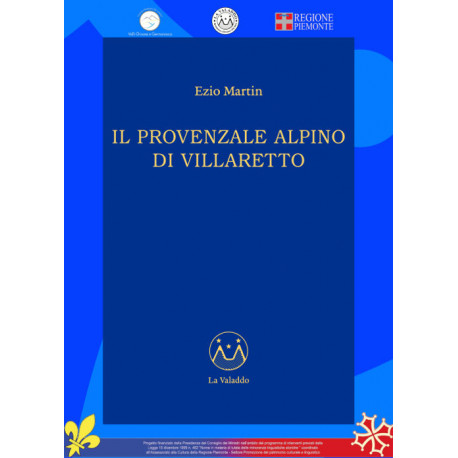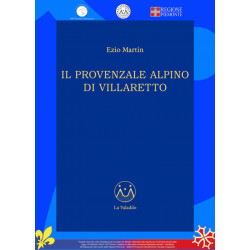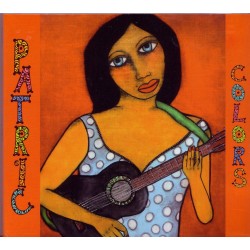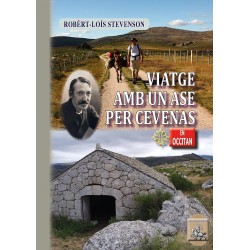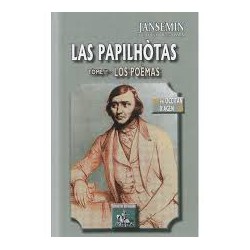Recently added item(s)
No products
Product successfully added to your shopping cart
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Diccionari
- New Selection
- Books
- Music
- Videos - DVD
- Miscellaneous
- Revues, Journaux
Links
Il Provenzale Alpino di Villaretto - Ezio Martin
L-9791220075015
New
3 Items
Available
29,00 €
Il Provenzale Alpino di Villaretto - Ezio Martin. Dizionario e saggi sul patouà di Villaretto in Val Chisone. Riguardanti la storia, il lessico e la grammatica della parlata, e di testi in lingua. Il corpo dell'opera è preceduto da una descrizione sintetica della fonetica e della morfologia della parlata. Edizioni La Valaddo.
Data sheet
| Type | Paperback |
| Year | 2020 |
| Language | Italian + Occitan Vivaro-Alpin |
| Pages | 368 |
| Format | 17 x 2.4 x 24 cm |
| Distributor | Edizioni La Valaddo |
| ISBN | 979-12-200-7501-5 |
More info
Il Provenzale Alpino di Villaretto - Ezio Martin
Dizionario e saggi sul patouà di Villaretto in Val Chisone
Risalendo la valle del Chisone, Villaretto, nel comune di Roure, è la prima località dove il patouà occitano presenta tutti i fenomeni più tipici delle parlate dell'alta valle, ma la sua posizione, in una zona esposta alle influenze provenienti dal davòl (la bassa valle), lo rende una varietà di "frontiera", all'interno della più vasta area delle parlate occitane cisalpine, particolarmente degna di attenzione.
Questo volume contiene il dizionario del patouà di Villaretto realizzato da Ezio Martin, composto da più di seimila voci e accompagnato da una sezione italiano–patouà per facilitarne la consultazione; è arricchito di alcuni saggi pubblicati dall'autore, riguardanti la storia, il lessico e la grammatica della parlata, e di testi in lingua. Il corpo dell'opera è preceduto da una descrizione sintetica della fonetica e della morfologia della parlata.
Edizioni La Valaddo, Roure.
La pubblicazione, curata da Michele Tron, è stata realizzata grazie ai fondi della Legge 482/99 per la tutela delle lingue minoritarie storiche.
Indice:
Prefazione; Introduzione; Note di grammatica; Dizionario patouà–italiano; Dizionario italiano–patouà; Il nostro provenzale alpino; Come evolve un patouà; Coumà dire?; Toponimia alpina preromana; A propaus d'Alberjan; Il Codice Gouthier; Appendici; Bibliografia.
Article:
Curato dal nipote Michele Tron con la prefazione del prof. Matteo Rivoira dell’Atlante Linguistico Italiano, è stato pubblicato, a cura dell’Associazione culturale La Valaddo di Villaretto Chisone - Roure, il dizionario del patouà di questo paese dell’Alta Val Chisone, del Pro. Ezio Martin. Arricchito da Note di grammatica e da alcune carte linguistiche che ci permettono di comprendere le differenti isoglosse fonetiche che caratterizzano questa parte valliva, un tempo nota come Escarton de Pragela, facente parte dell’antica Repubblica degli Escartons e da una parte finale che raccoglie alcuni scritti pubblicati a suo tempo sulla rivista La Valaddo, è il frutto di una raccolta lessicale pluridecennale.
Ezio Martin, di famiglia originaria di Villaretto, classe 1921, si laureò, passata la II seconda guerra mondiale nel 1947, con una tesi in Glottologia dal titolo: Il Regresso del “patois” in val Chisone. Sicuramente questo lavoro di ricerca fu la prima tesi di laurea assegnata sulle valli occitane, dall’Ateneo Torinese. Passeranno parecchi anni (1963) per ritrovare un secondo lavoro dedicato alla Val Chisone: La Parlata Provenzaleggiante di Inverso Pinasca (Torino) pubblicato nel 1966, di Ilia Griset.
Il prof. Martin, già insegnante a Lione e successivamente a Pinerolo, ha sempre coltivato l’amore per la propria parlata nativa, tanté che a partire dal primo numero del giornale La Valaddo del lontano novembre del 1968, dette la sua preziosa collaborazione. I testi in patouà venivano da lui messi in “ bella copia”, con una coerenza minuziosa. Sempre su La Valaddo, nel luglio del 1970 apparve una prima stesura di un Lessico del Patois di Villaretto mentre aveva già iniziato, con Vocalismo e Consonantismo del Patois di Villaretto, una minuziosa descrizione della parlata.
Nello stesso numero del luglio 1970 E. Martin annncia il ritrovamento di quel documento che passerà alla storia come il Codice Gouthier, del 1532 e 1549, ordinanze della comunità di Mentoulles, scritte nell’occitano cancelleresco e testimone della parlata alto valligiana di quell’epoca.
Il dizionario si divide in due parti: patouà -italiano e viceversa precedute da una necessaria lista delle abbreviazioni. La grafia utilizzata è una grafia che in parte riprende quella dell’Escolo dóu Po, anche definita concordata, in parte utilizza dei grafemi particolari come la ḙ < i (j) intervocalica tipica della parlata villarettese, ex: abaḙsô < abaissar “abbassare”, laḙt < lait “ latte”. Questo passaggio di i intervocalica a e, era già stato segnalato da J. Ronjat è pure presente a Valloriate ( Valle Stura) in posizione finale : vae < vai “va”, alae < alai “ la”. Ritroviamo questo fenomeno nel Forez, a S.t Bonnet le Château. A Villaretto in questo caso la a, in posizione tonica velarizza a> å, trascritta da Martin sempre con ò, ex: avòl < aval “ a valle”, jòp [ʤåp] < jap “latrato”, jòri [ʤåri] < jarri “topo”.
Martin non segnala invece una particolarità della parlata villarettese, limitandosi a segnalare il passaggio di â lunga degli infiniti verbali ad ô, dopo la caduta di r, ex: -Are > ar> â > ô. Anche in questo caso si tratta della velarizzazione di a tonica. L’allungamento vocalico provoca nella parlata villarettese una forma che possiamo trascrivere aggiungendo alla vocale una ª apicale, ex: parloª < parlar, dīnoª < disnar “ desinare”. Questo fenomeno comunque non è solamente legato alle forme verbali provenienti da – Are ma è presente in tutte le desinenze finali lunghe, sia verbali che sostantivali: ex. dürmiª “ dormire”, sabeª “sapere”, proª “prati”, ʤurnoª “ giornata”. Questa caratteristica è veramente caratterizzante della parlata villarettese, una specie di marchio di fabbrica che permette agli occitanofoni valchisonesi, di individuare con estrema precisione, gli appartenenti a questa comunità.
Il lessico contiene molte voci oggi completamente desuete e spesso sostituite da forme piemontesi o italiche adattate sommariamente alla fonetica villarettese.
Testimonio come il Prof. Martin tenesse molto ad un corretto uso linguistico, avendo ripreso un parente, abitante da anni a Torino, il quale si era permesso di utilizzare la forma Epifanió in luogo della forna loû/ li Reis.
In alcuni casi il Prof. Martin, sempre sul giornale La Valaddo, in alcuni studi dal titolo “ Come evolve un patouà” (1974), aveva già messo in risalto tali fenomeni di inquinameto linguistico.
Il dizionario contiene parecchie chicche lessicali come faralhô “ sperperare dissipare” già presente nel testo del Figliol Prodigo contenuto nella sua tesi di laurea o cërumḙô [ʧërümÿo:] “ nevicare” forse legata cërum “ segatura” o ecipatoḙro [e:ʧipatoÿro] “scappatoia”. Una vera sorpresa il verbo fènnhe “ fingere” con fentio “finta”che pensavo scomparso e ormai soppiantato da fa d’avis se non dal italico fa finto. Per ammissione dello stesso Martin lo ha reintrodotto così come l’occitano fègge “fegato”o ha inserito la sua proposta defiladdo per “sfilata” come il verbo amô “ amare”, inserito poiché era stato utilizzato in alcuni testi di Ugo Piton.
Sorprendono invece alcune lacune; vi è la voce agreno “pruno (frutto e pianta)” ma nel villarettese è pure conoscita la parola agreniè “ pianta del pruno”. Una considerazione simile va alla pianta detta ałiè “ sorbo bianco” ma manca la voce relativa ai frutti, appetiti dagli uccelli. Questi sono comunementi detti laz aliera o laz aliô.
Dal punto di vista fonetico stupiscono le forme legate a tetto, coperchio, coperta. Tutte vengono trascritte con ou in luogo di u [ ü]. Mi risulta che in villarettese le forme siano cubèrt, cubersel, cubèrto, che almeno per tetto è attestata pure nel piccolo vocabolario, omaggio a Guido Ressent Un’ cleò dë parolla.
Sicuramente se il Prof. Ezio Martin, deceduto nel 2011, avesse potuto completare il suo lavoro avrebbe certamente colmato queste piccole dimenticanze lessicali e arrichito certamente il suo lavoro di ricerca che rimane comunque una raccolta stimolante e dal punto di vista redazionale ottima.
Franco Bronzat.
Reviews
No customer comments for the moment.
 English
English Français
Français Occitan
Occitan